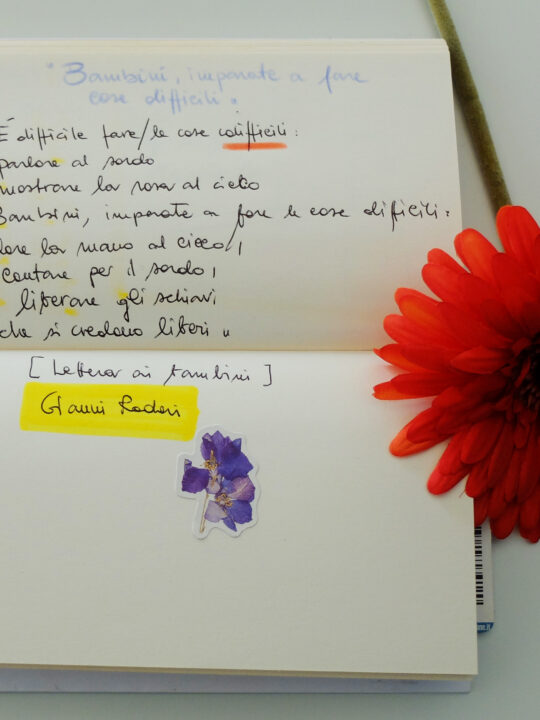L’antro del biciclettaio
Il posto dove porto a riparare la mia bicicletta appartiene a un altro mondo.
Sperduto in un dedalo di stradine popolari dove non ci si stupisce di vedere ancora botteghe di artigiani quali il “radiatorista” e il calzolaio, oppure l’enoteca con l’insegna della “Peroni” rappresentante un logo che non ricordo di aver mai visto sulle etichette delle bottiglie nei miei (quasi) quarant’anni di vita, si incontra questo locale alla strada, con una porta dalle ante in legno dipinto di grigio e le vetrate opache, che in tempi remoti devono essere state trasparenti.
Potrebbe essere, in tutto e per tutto, la classica bottega di un presepe, se la cosa non costituisse un clamoroso falso storico. Del resto la tradizione napoletana ci ha abituati da sempre a questo tipo di incongruenze: dubito che la Galilea di duemilatredici anni fa fosse piena di arrotini, salumieri e pizzaioli come lo sono le nostre piccole riproduzioni della natività. Dunque, se vi va, siete liberi di immaginarlo in un mondo miniaturizzato di sughero e muschio.
Le pareti, ricoperte da intonaco bianco ormai quasi completamente scrostato, sono tappezzate con poster dei grandi ciclisti della storia e articoli di giornale che esaltano qualche storica impresa su due ruote. Al di sopra dell’arco che sorregge la volta, una mensola obliqua ospita una ventina fra coppe e trofei di gare ciclistiche, ormai ricoperte da una patina di polvere e grasso. E’ un antro di tre metri per cinque che trasuda amore per le due ruote in ogni angolo consumato, in ogni attrezzo unto.
Tutto il resto dello spazio è occupato da vecchie biciclette, ruote, copertoni, camere d’aria, manubri, telai, in una catasta alta quasi due metri in mezzo alla quale chiunque rinuncerebbe a cercare persino un lingotto d’oro. Sono sicuro che il mio biciclettaio saprebbe trovare ad occhi chiusi qualsiasi pezzo gli fosse necessario. Solo una parete rimane più o meno libera dai pezzi di ricambio, ed ospita il banco di lavoro – rigorosamente in legno grezzo, protetto da uno strato di grasso che ormai lo avvolge meglio di qualsiasi stucco, laminato o cera. Da ogni cassetto straripano vecchi taccuini, fili d’acciaio, raggi per le ruote, bulloni, pattini dei freni. Sul lato una vecchia fresa nascosta fra arnesi e sgabelli lo costringe ad acrobazie improbabili per raggiungere i suoi bracci rotanti, in barba a qualsiasi regola di sicurezza sul lavoro. Più in là un compressore d’aria, sepolto da altri attrezzi, ha l’aspetto di un oggetto non usato da un pezzo. In mezzo c’è il più vecchio degli strumenti di misura: una bacinella piena d’acqua ingrigita, appoggiata su un supporto di ferro, che serve a scovare le perdite delle camere d’aria forate.
Per il mio artigiano non esiste una bicicletta che non sia degna di rispetto, anzi: giurerei che fra le mie due bici lui tratti con più amore la Bianchi di venticinque anni fa, e non la tecnologicissima Original 5 rossa fiammante a 18 rapporti. E, soprattutto, non esiste guasto che non possa essere riparato: gli bastano una chiave inglese, una pinza e le sue mani che si muovo rapide, esperte, e in pochi secondi ogni ruota dentata, ogni catena, ogni pedale torna al suo posto.
Contravvenendo a ogni regola di economia capitalistica, il compagno biciclettaio non si rassegna a dover cambiare il pezzo finché non raggiunge la dolorosa consapevolezza di non poter fare più niente per lui. E succede raramente.
Artigiani come lui – totalmente avulsi dal contesto frenetico e organizzato del mondo del lavoro moderno – sono avamposti di un mondo migliore, nonostante le apparenze, e meriterebbero un riconoscimento speciale, in barba all’automazione delle linee industriali e alla cultura dell’obsolescenza programmata.
Se lascio la mia vecchia Bianchi da lui, per una notte, so che lì dentro non ci troverà fantasmi – nonostante l’angustia del luogo – ma solo vecchi amici.