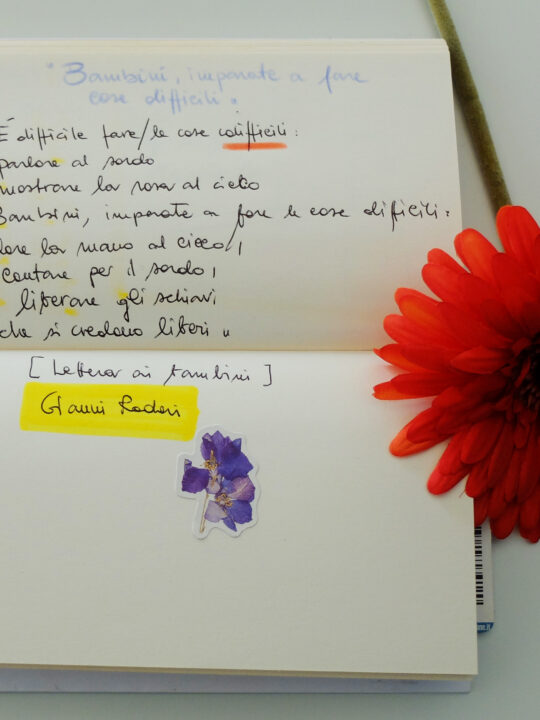Una foto ci salva la vita: pro e contro del “selfie”
Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, sembra essere la parola più utilizzata negli ultimi due anni. Il termine “selfie”, rappesenta una forma di autoritratto fotografico realizzato principalmente attraverso uno smartphone, un tablet o una fotocamera digitale, rivolte verso se stessi o verso uno specchio.
Questa moda, esplosa con l’avvento degli smartphone e con una nuova forma di corteggiamento virtuale, oggi sembra avere anche una funzione salvavita. A dimostrarlo è stata una donna canadese, Stacey Yepes, protagonista dell’importanza che possono avere gli strumenti tecnologici, anche per la salute.
“La donna era andata in un ospedale di Toronto affermando di aver avuto per qualche minuto difficoltà a parlare e un irrigidimento del volto: i medici avevano associato i disturbi a semplici sintomi dovuti allo stress, in quanto non avevano avuto modo di osservare la paziente durante l’attacco. Due giorni dopo, mentre era alla guida, la donna ha avuto un secondo attacco, e questa volta lo ha filmato con il suo cellulare, unitamente a tutta una serie di autoscatti. L’idea della donna è stata geniale e le ha permesso di salvarsi la vita: filmandosi durante l’attacco è riuscita ad ottenere una diagnosi corretta che la descrizione a voce dei sintomi non era riuscita a far trovare”.
Il video, visionato subito dopo dai medici, ha permesso loro di capire che non si trattava di semplice stress ma di ‘attacchi ischemici transitori’, salvandole così la vita.
Ho riportato la notizia, per introdurre l’aspetto psicologico correlato all’ormai famoso autoscatto.
Il selfie è la moda – direi quasi necessità giovanile – di ritrarsi in fotografie e poi pubblicarle in rete in tempo reale.
Fino a non molto tempo fa, una fotografia veniva scattata quando si viveva un particolare momento della propria esistenza da cogliere o da immortalare nel tempo: una vacanza, una abbraccio, un paesaggio, il sorriso di un figlio o di un amore e così via…
Oggi, il percorso è esattamente il contrario: si crea una condizione per poterla fotografare ed immediatamente postare online, come se il mondo facesse da sfondo ad un protagonismo imperante.
Più condivisioni e “mi piace” verranno associati all’ evento e più il protagonista del post sarà felice ed appagato dalla sua “dimensione online” e dalla sua esistenza.
Questo fenomeno viene osservato con sospetto da noi clinici, arriva dall’America ed è una vera patologia legata al “mancato riconoscimento del proprio corpo” .
Molti adolescenti con un’ immagine corporea fluttuante, invece di fermarsi a riflettere con i genitori o con i clinici di riferimento, su cosa non va e su cosa realmente manca alla loro autostima, trascorrono ore ed ore allo specchio, dietro l’obiettivo del loro smartphone.
La ricerca dell’autoscatto compulsivo, fa trasparire infinite fragilità e lacune, apparentemente colmate dalla foto più carina, che riceverà poi infinite condivisioni virtuali. Sono ragazzi che non riescono ad “essere” quello che vogliono, che soffrono per una mancanza cronica di identità, la cui unica forma di appagamento è “apparire” ed essere visti.
Sono ragazzi la cui immagine interiore non corrisponde quasi mai a quella esteriore.
Da clinico e da mamma, mi pongo infinite domande:
– Quali significati psicologici cela il selfie?
– Quanto può essere rassicurante una bella foto di sè?
– Eccesso di vanità o autostima carente?
– Quanto può durare il beneficio interiore di una bella immagine?
– Quante foto diventano necessarie per nutrire autostime vacillanti?
– Cure psicologiche o autoscatti?
Il Selfie è un segno forte e chiaro di un “passaggio”, equivale a dire “ci sono” per imprimere la propria immagine e condividerla con la rete, i social ed il mondo intero.
Il datato “cogito ergo sum” sembra essere stato sostituito da “esisto, solo se online”.
Questa nuova esigenza mediatica non è innocua come potrebbe sembrare.
Giunge in questi giorni, dall’APA, anche la conferma ufficiale che qualche cosa non va nella psiche dell’ “auto-ritrattista”.
La nuova patologia ha anche un nome: “selfitis, selfite”.
Secondo i membri dell’APA (American Psychological Association), chi ne è colpito soffre di un“desiderio ossessivo compulsivo” di realizzare fotografie di sé stesso per poi pubblicarle online, pratica messa in atto per compensare la mancanza di autostima ed anche per colmare svariate lacune nella propria intimità ed identità.
La selfite, equivale dal punto di vista clinico ad un disforfismo corporeo, una forma di sofferenza psicologica e di disagio, di chi vive con estrema ansia la propria immagine corporea.
Un esempio tipico è rappresentato da una ragazza anoressica, che vede la propria immagine allo specchio, sempre chiaramente in sovrappeso.
Non si tratta di psicologizzare ogni cosa, ma di leggere con un altro sguardo una pratica che oggi ha assunto il carattere di una vera e propria “epidemia virtuale”.
Conclusioni e riflessioni
Il web, utilizzato per creare e mantenere legami, o addirittura come nel caso della news per salvarsi la vita, non è sempre da demonizzare.
La generalizzazione della rete, che di fatto la rende fautrice di mostruosità relazionali, non sempre trova un riscontro reale, è invece l’utilizzo che se ne fa che non è sempre sano. Qualunque mezzo adoperato per facilitare incontri e relazioni, non elude la necessità di mantenere in vita i capisaldi di una “sana identità”.
Quando si adopera l’etere in maniera compulsiva e compensatoria, come nel caso di un selfie continuativo, è sicuramente spia di un disagio personologico e relazionale (in psicologia viene detto “falso sé”); in questi casi non è il web che deve essere demonizzato, ma bisognerebbe spostare l’attenzione sulla persona e sulla modalità di utilizzo, spesso “alternativo” e non propedeutico e funzionale alla qualità di vita.
fonte:
http://www.vitadidonna.org/salute/11189-salvata-da-un-selfie-che-filma-il-suo-mini-ictus.html