Amore chimico di Davide Venticinque (parte 6 e link alle altre)
Quarta di copertina
«Ho rimorchiato una tipa» le disse, era per la coca, non si vantava di solito. Ma Rossana lo sapeva e lo capiva, era quello il bello. Con certe persone sai di non essere mai sbagliato.
L’amore ai tempi della droga è un modo per toccarsi senza essere realmente vicini. Amore chimico è la storia di giovani in cerca di risposte e identità, in precario equilibrio sul filo della vita.
© tutti i diritti riservati
è possibile riprodurre in parte citando la fonte.
Compra Amore chimico da Feltrinelli o da Amazon su Colori Vivaci Magazine
http://www.lafeltrinelli.it/ebook/venticinque-davide/amore-chimico/9788891097583 ebook
http://www.lafeltrinelli.it/libri/venticinque-davide/amore-chimico/9788891096418 Libro
http://www.amazon.it/Amore-chimico-Davide-Venticinque-ebook/dp/B0123XJDS6/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr ebook Amazon
segue da parte 5
LA GIORNATA LUNGA E LENTA COME LA BAVA DI UNA LUMACA STANCA
SIMONE
Simone si era alzato coi postumi di una nottata brava, annebbiato e confuso. La sua mente aveva sofferto al suono insistente della sveglia e aveva sofferto il suo cuscino della loro separazione.
Un caffè di corsa e la sigaretta accesa appena montato in macchina, il giornale radio e le solite notizie del cazzo mentre intorno la città si sveglia e ti aggredisce.
Era arrivato in fabbrica puntuale, come al solito, pochi cenni di saluto con i colleghi, fantasmi lontani anche loro, con l’identità lasciata altrove, e si ero messo a lavoro.
Il macchinario a cui lavorava era enorme, nero e silenzioso, aspettava Simone, come ogni giorno. Fori in pezzi di metallo, ecco cosa faceva, la macchina scaldava i pezzi e lui con una trivella forava e calibrava. Otto ore al giorno, cinque giorni a settimana, da due anni.
Accese la macchina e fece partire la trivella. Fu un attimo, un rumore metallico gli riempì la testa, poi scintille e proiettili neri gli schizzarono davanti agli occhi. A momenti moriva.
La macchina si bloccò con uno sferragliare pazzesco, ci mise qualche secondo a capire che era tutto intero, che non sanguinava, le sue gambe non smettevano di tremare.
«Uè pirla!»
Era il suo capo che con un dito gli pungolava la schiena.
«Uè ma si può sapere cosa cazzo fai? Mi vuoi mandare in rovina mi vuoi? Ma dove cazzo è che vi vado a pescare io, ma guarda te guarda!»
«Scusi ma avevano lasciato dentro un pezzo freddo come facevo a saperlo? A momenti morivo.»
«Te mi hai fatto cinquecento euro di danno mi hai fatto, altro che! Sistema tutto sistema. Ma guarda te sto’ pirla guarda.»
Se ne era andato.
Simone con le gambe che ancora tremavano e i suoi pirla che rimbombavano nella fabbrica che andava riempiendosi si era acceso una sigaretta. Le sue mani avevano un leggero tremore, ci poteva perdere un occhio o un pezzo del cranio, roba da non crederci. Era andato alla finestra sudicia e aveva guardato fuori, il cortile col parcheggio e oltre il muro i cipressi alti, sulla campagna invasa e devastata dal metallo e dal cemento.
Dopo aver fumato si sentiva più tranquillo o quanto meno non tremava più. Era tornato alla macchina, controllato che fosse spenta e aperto il portello di carico, ci avrebbe messo ore a ripulire tutto. Era pieno di schegge nere e pezzi di metallo, aveva indossato i guanti e cominciato a lavorare.
Era lì curvo da due ore quando il suo capo era tornato, con le sue dita fastidiose a pungolargli la schiena.
«Uè pirla, ancora a pulire sei? Mi hai fatto cinquecento euro di danno mi hai fatto, vedi di darti una mossa.»
Senza dir niente Simone aveva continuato il suo lavoro. A un certo punto era dovuto andare in officina a farsi dare un aspiratore, la polvere e le schegge non poteva toglierle a mano, se avesse fatto ripartire la macchina con qualche residuo dentro sarebbe stato un casino. E ancora quelle dita sulla sua spalla.
«Uè allora? Ancora a pulire sei? Dai che devi lavorare dai! Mi hai fatto cinquecento euro di danno mi hai fatto, ma guarda te con chi ho a che fare!»
«Ascolti,» aveva detto Simone tranquillo «non potevo sapere che avevano lasciato un pezzo freddo qua dentro, quasi ci rimettevo un occhio, certo avrei potuto controllare e qui ho sbagliato, ma ora che dovrei fare?»
«Ti devi sbrigare. Ecco che devi fare, io ti pago per lavorare non per rimediare alle tue cazzate.»
Se ne era andato, col suo passo pesante e rancoroso. Simone lo compativa, non era colpa sua del resto, erano vent’anni che lavorava in quel buco, venti anni fa probabilmente era un ragazzo tranquillo come lui, ora forse lo aveva scordato. Il lavoro, giorno dopo giorno, la sveglia e aspettare la busta paga per spendere qualcosa, gratificarsi nel consumismo, essere come gli altri per non essere escluso. Dopo tutto è una questione di sopravvivenza.
Aveva quasi finito, erano passate le tredici da poco, i suoi colleghi erano andati a pranzo e lui ancora lì col suo lavoro… E ancora quelle dita sulla schiena.
«Allora pirla t’he’ finì? Mi hai fatto cinquecento euro di danno mi hai fatto, e mi hai rallentato la produzione, che devo fare io toglierti i soldi dalla paga? Dimmi che devo fare?»
Lo aveva guardato, nei suoi calzoni troppo larghi, le sue mani consumate dal lavoro, le sue orecchie ormai da buttare e il tono della voce sempre troppo alto, anche quando le macchine non andavano. Tra vent’anni, forse, sarebbe stato come lui.
Era in quel forse la sua salvezza.
Così sfilò i guanti e il camice e glieli mise in mano.
«Facciamo che ti finisci il lavoro da solo pirla, io me ne vado. Mi licenzio» che suono che aveva quella frase, un bel suono rotondo, raro, definitivo.
Quello spalancò la bocca e non disse nulla, non era più il capo d’altronde e non aveva più nulla da dire, per alcuni funziona così.
Simone si voltò e si accese una sigaretta, avrebbe chiamato Matteo, chissà dov’era, magari si sarebbero visti per una birra in giro; fuori il sole lo attendeva, ne aveva abbastanza della fredda luce dei neon, era il momento di andare.
POMERIGGIO LIBERO
Simone schiacciava l’acceleratore, c’era traffico, come al solito. Chilometri di asfalto grigio lo separavano dal suo meritato riposo, dal togliersi di dosso definitivamente le scorie del suo vecchio lavoro.
Gli serviva una canna, due chiacchiere e tre risate. Questo gli serviva, e una birra ghiacciata magari da lì a poco.
Matteo aveva una bella casa in campagna, la campagna ti dà la giusta prospettiva. C’è bisogno di allontanarsi, staccarsi dal trantran di ogni giorno, dai nostri affanni. Serve guardar le cose da un altro punto di vista.
Aveva il clacson rotto Simone, una sventura. Il clacson è uno strumento terapeutico indispensabile in certe occasioni. Era costretto a sporgersi dal finestrino e urlare per sfogarsi in quella bolgia.
Chissà Matteo cosa cazzo combinava. Sicuramente era già rientrato da lavoro. Buon vecchio Matteo, non faceva che scopare, aveva due storie con due fighe diverse, se la spassava, a Simone sembrava giusto.
Era il compagno ideale di un party Matteo. La giusta frequenza d’onda e vibrazione. I loro ritmi erano simili, ed erano simili alla musica, alla roba che avevano in corpo quando ballavano.
Si sfogavano, come potevano, il sabato era giorno di guerra e loro da bravi soldati, con belli elmetti, avrebbero fatto la loro parte e magari issata una cazzo di bandiera.
Quando uscivano per andare a ballare erano un tintinnio di moschettoni e chiavi. Nella stanza dove erano raccattavano portafogli, cappellini, marsupi e tasche traverse. Stringevano le cinghie delle scarpe pesanti, Simone ne aveva un paio da cantiere con punta in metallo e lastra di acciaio a proteggere la pianta del piede. Si guardavano, vestiti di scuro, in tre o
quattro, una squadra da assalto, se avevano già tirato dello speed erano peggio di quattro incursori.
Arrivò da Matteo. Dalla finestra aperta Jimi Hendrix diffondeva il suono della sua chitarra che sembrava suonata con l’anima e con lo stomaco. Erano in pochi i musicisti toccati da quello spirito divino.
Suonò alla porta e Matteo aprì, col sorriso sul volto di chi non ti aspetta ed è contento di vederti.
Simone ricambiò il sorriso, i suoi capelli rossi illuminati da dietro, dall’ultima coraggiosa luce del sole, i suoi occhi chiari, sembrava non aver mai sofferto ed esser destinato a non farlo mai.
«Tu non dovresti essere a lavoro?» chiese Matteo.
E Simone: «Si fotta il lavoro».
«Sagge parole, entra che ti offro una birra e facciamo una canna.»
«Queste sono sagge parole fratello.»
Chiusero la porta ed entrarono nell’ampia sala inondata dal tramonto.
I padroni di casa di Matteo avevano avuto buon gusto, lei era architetto e scopava con Matteo, aveva un corpo da sballo. Simone l’aveva incontrata un paio di volte, a vederla l’avresti detta una santa, discreta, silenziosa, era proprio vero che sono le più pericolose.
«Com’è che non sei andato a lavoro?» chiese Matteo mentre il fumo si diffondeva pigro nella stanza.
«Ci sono andato, mi hanno rotto i coglioni a raffica, per poco non morivo, mi è scoppiata una cazzo di macchina in faccia.»
«Cosa?!»
«Sì, lascia stare guarda. Il mio capo, quel cornuto, mi toccava con ‘sto cazzo di dito sulla spalla – Oh hai finito pirla? – mi sono tolto il camice e l’ho mandato affanculo, mi sono licenziato. Sono libero, libero cazzo.»
«Tu sei sempre stato libero.»
«Sì ma quando stai in fabbrica nove, dieci ore al giorno, alla luce del neon, è difficile sentirsi liberi.»
«Ascolta, tu sei nato in Romania, hai girato mezzo mondo prima di compiere quindici anni, a te pesa di più stare chiuso in un posto, ma nessuno, proprio per quello che sei, può privarti della libertà. In una parte di te, fossi anche in catene, saresti libero» disse Matteo.
«Sì ma le catene le evito e così i lavori del cazzo che dopo un po’ proprio non reggo» fece Simone.
«Perché non torni al circo?»
Simone apparteneva a una famiglia circense, sua madre e suo padre erano trapezisti, lui era andato via dal circo quando era l’attrazione principale, lanciatore di coltelli, il più giovane al mondo, la lama più veloce, la mano più ferma, così lo presentavano quando entrava in scena.
«Ma lascia stare… Sono troppo libero appunto, per seguire le carovane, se mi va di restare in un posto devo poterlo fare, se mi va di andare devo prender su e partire. Chi segue il gregge finisce per calpestare la merda.»
In effetti, da quando Matteo lo conosceva, Simone aveva vissuto in sei città diverse, quella era la seconda volta che viveva a Bologna e chissà per quanto ci sarebbe rimasto.
«Già» disse Matteo. «Resti a cena vero?»
«Va bene ma cucino io.»
«Ovvio.»
Simone era un cuoco incredibile e poi starlo a guardare mentre affettava le verdure o qualsiasi altra cosa era un vero spettacolo. Matteo aveva persino comprato un set di coltelli per quando andava a trovarlo. Si muoveva con una velocità assurda, usava spesso due lame, una per mano, le scambiava al volo, tagliava la roba mentre la passava da una mano all’altra, roba da non credere. Aveva poi ottimo gusto estetico, i suoi piatti erano sempre degli abbinamenti appetitosi di colori e sapori.
«Come va con Lana?» chiese Simone mentre cucinava.
«Bene. Solo che ho voglia di scoparla e non lo faccio da tre giorni.»
«L’importante e che non ti rompa il cazzo. Sta ancora col tipo no?»
«Sì.»
«Meglio, finché ha un uomo a lui romperà il cazzo per gli strippi che tutte le donne hanno, a te darà solo piacere.»
«Già». Disse Matteo, ma Simone gli vide come un’ombra negli occhi.
«L’altra?… Silvia. La vedi ancora?»
«Sì.»
«Oh, sei un cazzo di scopatore. Io non scopo da… da tanto che l’ho scordato.»
«La figa è come la pioggia, bisogna raccoglierla quando c’è.»
«Mezz’ora e mangiamo. Fai un’altra canna, che io sto qui a cucinare e tu non fai un cazzo!»
«Hai ragione» e si mise seduto a far qualcosa anche Matteo.
La serata passò leggera, Matteo quasi non pensò a Lana, solo di tanto in tanto si ritrovava assorto, in silenzio, mentre costruiva con pacchetti di sigarette, accendini e quello che si trovava per le mani assurde torri fragili. Ma bastava la voce dell’amico a farlo tornare.
Simone non pensò al fatto che doveva trovarsi a breve un nuovo lavoro, aveva i soldi per tirare avanti un paio di mesi, poi sarebbe stato in mezzo a una strada, era una cosa che aveva già affrontato e non gli faceva paura.
Fuori il mondo, coi suoi affanni, continuava a girare.
DA DONNA IN DONNA
La mattina Matteo si svegliò per andare a lavoro, baciò Lana sulle labbra carnose, lentamente, lei lo abbracciò. Poi andò via lasciandola tra le bianche lenzuola arrotolata e coi capelli arruffati.
Il sole fuori non era mai stato così luminoso.
Quando la sera tornò da lavoro trovò un biglietto appiccicato sul suo frigorifero, era celeste, di grezza carta porosa, con inchiostro azzurro c’era scritto:
“Grazie di tutto. Sono stata molto bene, ora va peggio ma me lo merito e sopravvivrò. Bacini…”.
Lui andò in bagno con il sorriso ed il suo odore addosso, non aveva voluto fare la doccia, strapparsi di dosso quella sensazione di sesso, di caldo tepore, sentiva ancora il suo respiro pieno di lei.
Quando squillò il telefono era in accappatoio, a piedi nudi, la Terza Sonata per piano di Chopin si diffondeva nella stanza.
«Pronto?»
«Matte sono Silvia come stai?»
«Bene, tu che combini?»
«Studio per lo più. Hai impegni stasera?»
«No, cosa proponi?»
«Ristorante Messicano e un sacco di tequila.»
«Ci sto» disse lui, si era eccitato.
Passò a prenderla alle otto, era bella e intensa mentre scendeva le scale, coi capelli sciolti, neri e lucidi come il pelo di una gatta. Un vestito a tubo nero, un giro di perle al collo e la sua borsetta, sembrava uscita da un film anni cinquanta.
Lo sportello si chiuse, lei si chinò verso di lui leggera e lo baciò sulle labbra, altro odore altro sapore, e la notte davanti, con le sue strade, le sue voci, i suoi profumi, e la musica messicana, suonata con l’euforia di chi si gioca tutto e non ha niente.
Nel ristorante conversarono amabilmente, sapevano così poco in fondo l’uno dell’altra.
Silvia aveva vissuto a Genova fino ai diciotto anni, si era diplomata al liceo, poi l’università. I suoi si erano separati che lei era piccola, sette anni, l’inferno che aveva passato per un secondo le si era affacciato sul volto. Poi lei lo aveva cacciato, nel profondo dell’animo, ed era tornata a sorridere. Era dolce, delicata ed educata, la sua era una famiglia di armatori, aveva passato la sua adolescenza tra ricchi salotti e pranzi di gala. Etichetta e bon ton, involucri in cui mascherare le personalità. Aveva una sorella, dopo la separazione era stata affidata alla madre, Silvia al padre. Si vedevano a scuola e una volta a settimana a casa di uno dei due genitori, qui il suo viso tornò a farsi scuro per un attimo mentre raccontava, come se di quei pomeriggi non conservasse un buon ricordo. Poi tornò a sorridere.
«Ora ci vediamo abbastanza spesso, lei vive a Firenze, è un archeologo. Tu sei figlio unico?»
«Sì. Ho avuto molti amici però e due cugini con cui sono cresciuto, ci picchiavamo di continuo. Quando ero ragazzino si giocava ancora per strada.»
«Io invece giocavo con la casa delle bambole» disse lei guardando nel vuoto.
SILVIA
LA CASA DELLE BAMBOLE
Silvia ha otto anni, un vestito rosa col pizzo San Carlo sulla scollatura appena accennata. Gioca con la casa delle bambole, è completamente presa dal gioco. Non pensa ad altro, lei ora è in quella casa, solo i bambini piccoli
e adulti con qualcosa di magico dentro riescono a farlo.
Nel gioco ha tre sorelle e un fratello maggiore, che le difende dai bimbi cattivi, una mamma affettuosa che compra loro ogni genere di schifezza al cioccolato e un papà, che fa il marinaio e spesso è lontano. La casa è grande, su due piani, lei dorme con le sorelle, il fratello nella stanza accanto. Si divertono la sera a preparare la cena tutti assieme, torte di tutti i tipi, per soddisfare i gusti di ognuno.
Poi un rumore la riporta alla realtà, di colpo, come quando ci si sveglia da un sogno e ci si sente per un attimo smarriti. È la porta della sua stanza che si apre.
Suo padre è tornato da lavoro, lei resta sola dopo la scuola per due, tre ore, il tempo tutto mio, lo chiama Silvia, ma ora è finito. Mette le bambole da parte, nella casa che è tornata ad essere un giocattolo di plastica, poi la solleva a fatica, e la ripone in un angolo. Suo padre non vuole roba in giro.
«Stai sempre a giocare» dice suo padre.
«Scusa papà, ma mi annoio a stare sola.»
«Ora non sei più sola piccola vieni dal tuo papà.»
Silvia si avvicina piano, con la testa bassa.
«Tuo padre è un bambino cattivo, sai cosa devi fare per farlo calmare vero? Quella troia di tua madre non le voleva fare certe cose.»
«Sì papà» dice lei.
Dai suoi occhi sgorgano lacrime che rigano le guance e cascano per terra, lei non ne capisce il senso, è troppo piccola, non sa nulla, solo quello che le accade.
Continua…
( parte 1) https://www.colorivivacimagazine.com/2015/12/amore-chimico-di-davide-venticinque-parte-1/
(parte 2) https://www.colorivivacimagazine.com/2015/12/amore-chimico-parte-2/
(parte 3) https://www.colorivivacimagazine.com/2015/12/amore-chimico-di-davide-venticinque-parte-3/
(parte 4) https://www.colorivivacimagazine.com/2015/12/amore-chimico-di-davide-venticinque-parte-4-2/
(parte 12) https://www.colorivivacimagazine.com/?s=amore+chimico
Crediti photo copertina Todd Hido







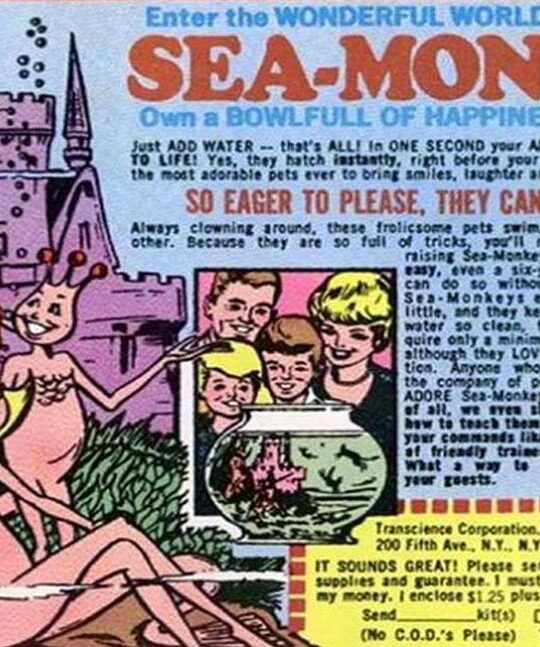

1 commento