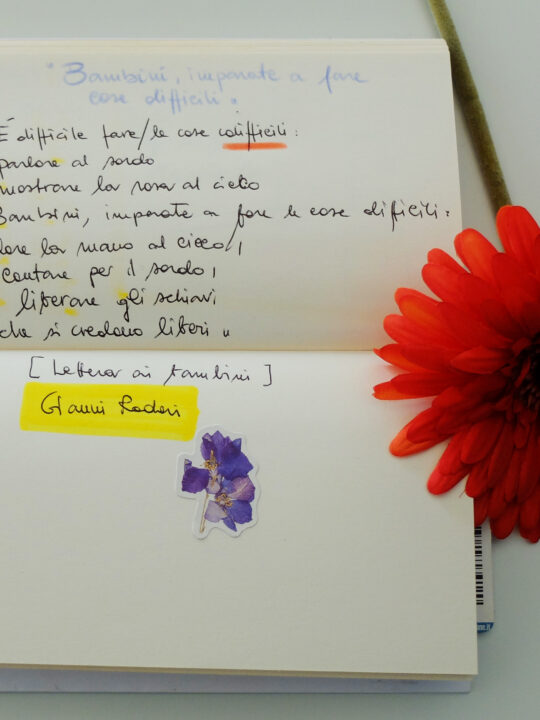Perché Nevermind?
Nevermind non è stato un album particolarmente ricercato né originale e, a dirla tutta, a mio avviso non è stato neanche il migliore dei Nirvana (“In utero” lo sovrasta in quanto a talento compositivo).
Oggi che leggo da più parti della ricorrenza del suo venticinquesimo compleanno, allora, provo a chiedermi perché.
Perché è stato uno degli album più importanti della mia generazione.
Perché è entrato a pieno titolo fra i giganti della musica leggera, pur non essendo un album “leggero” da nessun punto di vista: si tratta di musica ruvida e martellante, e se si scava un attimo sotto la superficie e si indaga sui contenuti ci si ritrova in un abisso ancor più profondo: il manifesto del disorientamento di un’intera generazione, tanto avveniristico da sembrare ancora attuale dopo un quarto di secolo.
Perché è stato l’ultimo disco che abbia davvero cambiato qualcosa nel mondo del rock.
Perché?
Mickey Rourke, nei panni di Randy “The Ram” Robinson nel film “The wrestler”, sintetizza tutto in una frase sfatta, odiosa ma geniale: “Cazzo non ne fanno più di canzoni così. Mitici gli anni ’80, imbattibili: i Guns N’ Roses sono i più forti, i Motley Crue, i Def Leppard… poi Cobain, quel finocchio è arrivato a rovinare tutto; noi volevamo solo divertirci, che c’è di male”.
Ecco, è tutto qui: non voglio dire che il rock, prima dei Nirvana, non avesse mai toccato temi seri, lotte sociali, depressioni e disagi, ma l’esplosione di Nevermind ha segnato uno spartiacque, ha demolito il falso mito degli anni ’80, ha tolto il velo a un inganno che era durato troppo, stava diventando rancido, la filosofia del “volere è potere” che ha funzionato da faro per tutti coloro che in quel decennio ci sono cresciuti e – arrivata la fine della cuccagna – si sono ritrovati a dover fare i conti con una realtà che nessuno gli aveva mai insegnato.
Il fatto che io sia tanto affascinato da figure del rock morte suicide – Kurt Cobain e Ian Curtis su tutte – potrebbe dar lavoro a frotte di psicologi, ma mi tengo l’adorazione per loro chiusa in un cassetto (lungi da me voler fare l’apologia del suicidio) e rifletto spesso sulla necessità e sui rischi del vivere la vita e le emozioni in maniera tanto radicale. Kurt l’ha fatto, ed è per questo che in tanti lo ammirano incondizionatamente, nonostante si sia rivelato – a conti fatti – uno che la sua battaglia con la vita l’ha persa. Aveva un gruppo rock lanciatissimo, una moglie una figlia che – fatti salvi gli inevitabili alti e bassi – amava visceralmente; cosa non ha funzionato? A volte è solo questione di un attimo e le stesse emozioni che ti hanno reso unico e inconfondibile, che hanno ispirato le tue opere e, di riflesso, la vita di milioni di persone, s’intromettono in una frattura di debolezza nella corteccia e ti fanno fuori.
Ma non è tutto qui, perché il secondo album dei Nirvana non è stato soltanto un manifesto nichilista, uno chiaroscuro inimitabile di poesia votata al rock: ha rappresentato un evento senza precedenti anche nell’ambito strettamente musicale, pur essendo – come detto – un insieme di canzoni che a conti fatti non avevano nulla di originale. Il terzetto di Aberdeen veniva da una radice profondamente punk, ma ha dimostrato che negli anni ’90 il punk non aveva più voglia di essere “duro e puro”: appariva contaminato, a volte addolcito, in certi tratti ripulito ma, nonostante tutto, continuava a mantenere la forza dirompente del genere da cui si era evoluto. Questa contaminazione è stata alla base del movimento grunge: fino ad allora esistevano i gruppi punk, quelli metal, gli psichedelici, le band di rock-blues. Nei primi anni ’90, a Seattle, si mischiava qualsiasi cosa in un grande calderone, ciascuno con la sua ricetta personale: i Mudhoney usavano molto punk e un pizzico di psichedelia, i Soundgarden attingevano a piene mani dal metal ma ne rifiutavano gli schemi preconfezionati, i Pearl jam avevano un’impronta più classic-rock, ma non disdegnavano né aperture melodiche né strizzatine d’occhio al ’77, i Rage against the machine, addirittura, impiantavano un cantato rap su un granitico sonoro rock, esperimento che fino a quel momento avevano tentato in pochissimi.
Nevermind, rispetto a tutti gli altri, ha avuto l’onere e l’onore di abbattere le barriere del mercato discografico e spianare la strada a decine di ottimi confratelli: riuscite ad immaginare una ruspa migliore dell’attacco di “Smells like teen spirit” per raggiungere un obbiettivo simile?
Manlio Ranieri

Perché Nevermind? di Manlio Ranieri è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
Permessi ulteriori rispetto alle finalità della presente licenza possono essere disponibili presso maulis@libero.it.
eBook a meno di un euro! :):