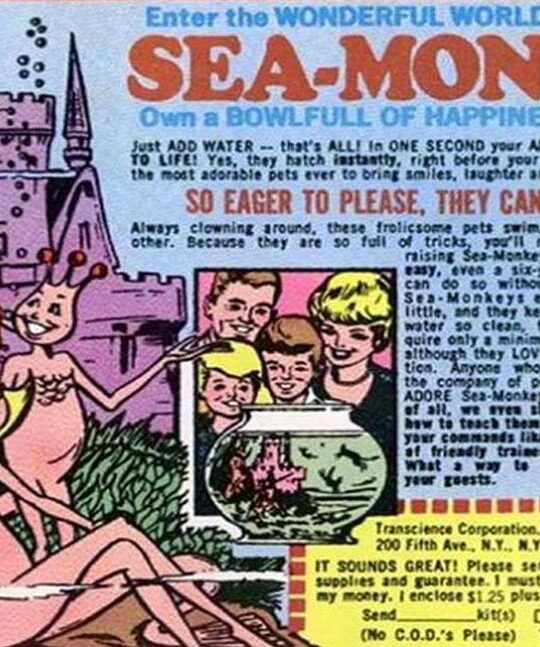Baudelaire e la fotografia
«Giacché la fotografia ci dà tutte le garanzie d’esattezza che si possono desiderare (credono questo, gli insensati!) l’arte è la fotografia».
Charles Baudelaire, Salon de 1859, 1859.
Sulla fotografia
È sorta in questi deplorevoli giorni una nuova industria che ha contribuito non poco a distruggere ciò che di divino forse restava nello spirito francese. È noto che la folla idolatra richiedeva un ideale degno di sé e conforme alla propria natura. In fatto di pittura e di statuaria, il Credo attuale della buona società, soprattutto in Francia (e ritengo che nessuno osi affermare il contrario), è questo: «Credo nella natura e non credo che nella natura (ci sono buone ragioni per questo). Credo che l’arte sia e non possa essere che la riproduzione esatta della natura (una setta timida e dissidente vuole che siano esclusi gli oggetti ripugnanti come un vaso da notte o uno scheletro). Sicché l’industria che ci desse un risultato identico alla natura sarebbe l’arte assoluta».
Un Dio vindice ha esaudito i voti di questa moltitudine. Daguerre fu il suo Messia. E allora essa disse tra sé: «Giacché la fotografia ci dà tutte le garanzie d’esattezza che si possono desiderare (credono questo, gli insensati!) l’arte è la fotografia». Da quel momento, l’immonda compagnia si precipitò, come un solo Narciso, a contemplare la propria triviale immagine sul metallo. Una follia, uno straordinario fanatismo s’impadronì di tutti questi nuovi adoratori del sole. Strane abominazioni si manifestarono.
Associando e raggnippando gaglioffi e gaglioffe agghindati come i macellai e le lavandaie a carnevale, pregando questi eroi di voler prolungare, durante il tempo necessario all’operazione, la loro smorfia di circostanza, ci si illuse di rendere le scene, tragiche o leggiadre, della storia antica. Qualche scrittore democratico ha dovuto vedere in ciò il mezzo di diffondere a buon mercato nel popolo il disgusto della storia e della pittura, commettendo così un doppio sacrilegio e insultando, ad un tempo, la divina pittura e l’arte sublime del commediante. Di lì a poco, migliaia di occhi avidi si chinarono sui buchi degli stereoscopi come sugli abbaini dell’infinito. L’amore dell’osceno, naturalmente vivo nel cuore dell’uomo quanto l’amore di sé, non lasciò sfuggire un’occasione così bella per soddisfarsi. E non si dica che i ragazzi di ritorno dalla scuola fossero i soli a godere di quelle porcherie; esse furono la frenesia della società. Ho udito una bella signora, una signora del bel mondo, non già del mio mondo, rispondere a coloro che le nascondevano con discrezione simili immagini, preoccupandosi così d’aver pudore per lei: «Mostrate pure, non c’è niente di troppo forte per me». Giuro di aver udito con le mie orecchie; ma chi mi crederà? «Vedete bene che si tratta di grandi dame!» dice Alessandro Dumas. «Ce ne sono di ancor più grandi!» dice Cazotte. Poiché l’industria fotografica era il rifugio di tutti i pittori mancati, scarsamente dotati o troppo pigri per compiere i loro i studi, questa frenesia universale aveva non solo il carattere dell’accecamento e dell’imbecillità, ma anche il colore d’una vendetta. Che un così stupido complotto, nel quale si trovano, come in tutti gli altri, i malvagi e i gonzi, possa riuscire in modo assoluto non credo, o almeno non voglio credere; ma sono convinto che i progressi male applicati della fotografia hanno contribuito molto, come d’altronde tutti i progressi puramente materiali, all’impoverimento del genio artistico francese, già così raro. La fatuità moderna avrà un bel ruggire, eruttare tutti i gorgoglii della sua tonda personalità, vomitare tutti i sofismi indigesti di cui una recente filosofia l’ha rimpinzata a crepapelle, ciò va inteso nel senso che l’industria, facendo irruzione nell’arte, ne diviene la più mortale nemica, e la confusione delle funzioni fa sì che nessuna sia compiuta a dovere. La poesia e il progresso sono due ambiziosi che si odiano d’un odio istintivo, e, quando s’incontrano sulla stessa strada, bisogna che uno dei due serva l’altro. Se si concede alla fotografia di sostituire l’arte in qualcuna delle sue funzioni, essa presto la soppianterà o la corromperà del tutto, grazie alla alleanza naturale che troverà nell’idiozia della moltitudine. Bisogna dunque che essa torni al suo vero compito, quello di essere la serva delle scienze e delle arti, ma la serva umilissima, come la stampa e la stenografìa, che non hanno né creato né sostituito la letteratura. Arricchisca pure rapidamente l’album del viaggiatore e ridia ai suoi occhi la precisione che può far difetto alla sua memoria, adorni pure la biblioteca del naturalista, ingrandisca gli animali microscopici, conforti perfino di qualche informazione le ipotesi dell’astronomo; sia, insomma, il segretario e il taccuino di chiunque nella sua professione ha bisogno d’un’assoluta esattezza materiale, fin qui nulla di meglio. Salvi pure dall’oblio le rovine cadenti, i libri, le stampe e i manoscritti che il tempo divora, le cose preziose di cui va sparendo la forma, che chiedono un posto negli archivi della nostra memoria: sarà ringraziata e applaudita. Ma se le si concede di usurpare il dominio dell’impalpabile e dell’immaginario, e di tutto quello che vale solo per quel tanto d’anima che l’uomo vi mette, allora poveri noi! So bene che parecchi mi diranno: «La malattia che siete venuto spiegando è quella degli imbecilli. Qual uomo, degno del nome d’artista, o che ami veramente l’arte, ha mai confuso l’arte con l’industria?». Lo so, eppure chiederò loro, a mia volta, se credono al contagio del bene e del male, all’azione delle folle sugli individui e all’obbedienza involontaria, forzata, dell’individuo alla folla. Che l’artista agisca sul pubblico, e che il pubblico reagisca sull’artista, è una legge incontestabile e inoppugnabile; d’altronde i fatti, terribili testimoni, sono facili a studiare; il disastro si può verificare. L’arte ha sempre meno il rispetto di se stessa, si pro-sterna davanti alla realtà esteriore, e il pittore si fa sempre più incline a dipingere, non già quello che sogna, ma quello che vede. Pure è una felicità sognare, ed era una gloria esprimere quello che si sognava; ma che dico? Conosce ancora, l’artista, questa felicità? Affermerà l’osservatore in buona fede che l’invasione della fotografia e la grande follia industriale sono assolutamente estranee a questo deplorevole risultato? È permesso supporre che un popolo i cui occhi si abituino a considerare i risultati d’una scienza materiale come prodotti del bello, dopo un certo tempo si trovi con la facoltà di giudicare e sentire ciò che vi è di più etereo e di più immateriale singolarmente attenuata?
Charles Baudelaire, Salon de 1859, 1859, trad. it. di A. Luzzato.