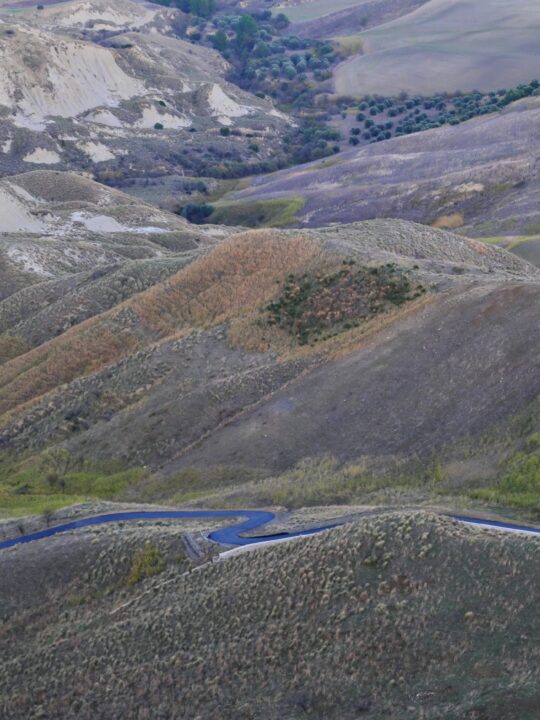Lettres de Gustave Flaubert à Louise Colet
Gustave Flaubert, durante una visita a Parigi nel luglio 1846, conosce la poetessa Louise Colet (nata Revoil), sposata a un flautista e amante del filosofo Victor Cousin, frequentatrice dei migliori salotti e spregiudicata. I due hanno subito una relazione molto coinvolgente, portata avanti fra contrasti dovuti in particolare al desiderio di indipendenza di Gustave. Pare che Louise Colet sia stata la musa ispiratrice del suo capolavoro Madame Bovary.
Alcune lettere:
Avrei potuto amarti in modo più piacevole per te. Infatuarmi della tua superficie e restar là. E’ quello che tu hai voluto a lungo. Ebbene no. Io sono andato al fondo. Non ho ammirato quello che tu mostravi, che tutti potevano vedere, che stupiva il pubblico. Sono andato al di là e ho scoperto dei tesori. Un uomo che tu avessi sedotto e dominato non si godrebbe come me il tuo cuore in ogni suo recesso. Quello che provo per te non è un frutto d’estate dalla buccia liscia, che cade dal ramo al minimo soffio e sparge sull’erba il suo succo vermiglio. Ha a che fare con il tronco, con la scorza dura come una noce di cocco, o guarnita di spine come i fichi d’india. Fa male alle dita, ma contiene del latte.
Come si fanno i bagni senza essere sporchi, mi sarebbe utile un gran bucato interiore.
Oh! no, sono io ad esser solo, ad esserlo sempre stato. Non hai osservato l’altro giorno a Mantes due o tre assenze durante le quali hai esclamato: «Che carattere lunatico! a cosa pensi?». A cosa, non so proprio, ma quel che non hai visto che raramente è il mio stato abituale. Non sto con nessuno, in nessun luogo, non appartengo al mio paese e forse al mondo. Mi circondano e io non sono circondato; così le assenze causatemi dalla morte non hanno portato all’anima mia un nuovo stato ma l’hanno perfezionato, questo stato. Ero solo, dentro, sono solo, fuori. Chi ho qui? Gente che m’ama, poca, una sola. Ma non è tutto, l’essere amato. La vita non consiste in effusioni di tenerezza. Sono cose belle, deliziose in certi momenti rari e solenni. Quel che rende i giorni lieti è la possibilità d’abbandono dell’anima, la comunione delle idee, le confidenze dei sogni fatti, dei desideri, dei pensieri; e quanta gente c’è quaggiù che abbia la stessa opinione anche solo su come dare una cena o attaccare i cavalli?
Ma ci sono tante cose curiose a questo mondo! soprattutto per un uomo che può dire come l’Angély: «Io vivo per curiosità», che non si riuscirebbe a vederle tutte. Sì, ho una profonda ripugnanza per i giornali, cioè per l’effimero, il passeggero, quello che è importante oggi e non o sarà domani. Non è insensibilità. Solo che io simpatizzo altrettanto, e forse più, con le miserie scomparse dei popoli morti a cui nessuno pensa, con tutte le grida che hanno lanciato e che non si sentono più. Non mi impietosisco sulla sorte delle classi operaie attuali più di quanto, o altrettanto, lo faccia sugli schiavi antichi che giravano la macina. Non sono più moderno che antico, più francese che cinese, e l’idea della patria, cioè dell’obbligo in cui si è di vivere su un angolo di terra segnato in rosso o in blu sulla carta e di detestare gli altri angoli in verde o in nero, mi è sempre parsa troppo stretta, limitata e di una feroce stupidità. Sono fratello in Dio di tutto ciò che vive, della giraffa e del coccodrillo come dell’uomo, e il concittadino di tutto ciò che abita il grande appartamento ammobiliato dell’universo. […] La poesia è una pianta selvatica. Cresce dove non la si semina. Il poeta non è che il botanico paziente che sale sui monti per andarla a cogliere.
Cento volte al giorno mi trattengo, pronto come sono a dire il tuo nome; su ogni nonnulla mi vengono sempre paragoni, rapporti, antitesi di cui sei tu il centro. Tutte le stelline del mio cuore convergono intorno al tuo pianeta, mio bell’astro.
Lavoro più che posso. Questo pomeriggio sono rimasto sette ore senza muovermi dalla mia poltrona, e stasera tre. Tutto ciò non vale due ore di lavoro ragionevole. La tua immagine mi viene sempre come una nebbiolina (sai, uno di quei vapori mattutini che danzano e salgono luminosi, aerei, rosati) fra i miei occhi e le righe che essi percorrono. Rileggo l’Eneide, di cui mi ripeto a sazietà qualche verso; mi bastano per molto tempo. Me ne stanco la mente da solo; ci sono frasi che mi restano nella testa e da cui sono ossessionato, come da quelle arie che ritornano sempre e che vi fanno male tanto vi piacciono.
Quel che mi impedisce di prendermi sul serio, anche se ho lo spirito piuttosto grave, è il fatto che mi trovo molto ridicolo, non di quella relativa ridicolaggine che fa la comicità teatrale, ma di quella ridicolaggine intrinseca alla vita umana di per se stessa e che balza fuori dall’azione più semplice, o dal gesto più comune. Per esempio mai mi faccio la barba senza ridere, tanto la cosa mi pare stupida. Tutto questo è molto difficile da spiegare: bisogna provarlo. Tu non lo puoi provare, tu che sei fatta d’un sol pezzo, come un bell’inno d’amore e di poesia. Io sono un arabesco d’intarsi, ci sono pezzi d’avorio, d’oro e di ferro. Ce ne sono di cartone dipinto. Ce ne sono di diamante. Ce ne sono di latta.