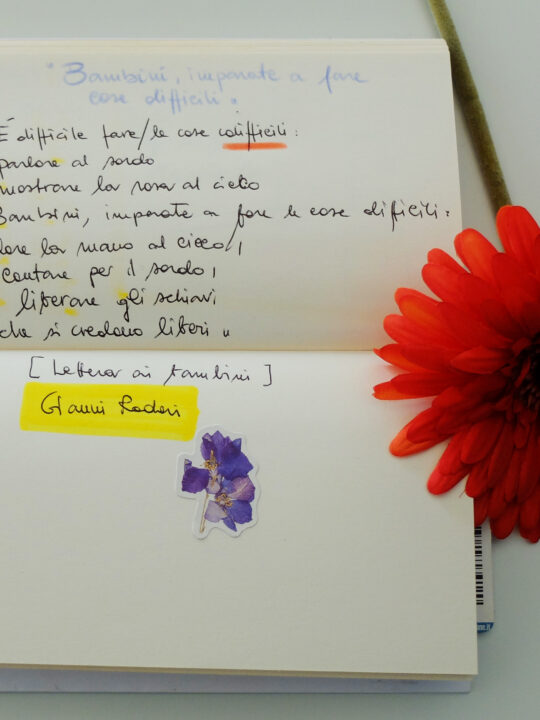Del massimalismo lunare e di altri mostri incauti
L’afasia meccanica rigurgita il tempo perso col vino e le donne e i rotocalchi. Per mancare un piccolo nirvana, al crocevia. Lì, in fondo, dove ogni giorno finisce il mozzicone, un pensiero ucciso o l’implicatura più velata, che qualunque indovino mormora a denti stretti, scucendo il morso di vipera. Quello di tanti anni fa,che hai riposto sul polso sinistro. Impercettibile come uno starnuto dalla’altro lato della strada. Puoi coglierlo a determinate condizioni, augurare salute, ma ti risponderà sempre e solo un sorriso imbarazzato. O al meglio un timido grazie sbigottito, che vuole nascondersi. È cortesia, palmo verso l’alto. Come quando ci si avvicina ad un cane anonimo randagio. Perché tutto è plausibile alla bocca dello stomaco, tranne l’indifferenza o la parola. Danzano i lampioni quando piove, ma il pensiero del riparo distoglie da ogni spettacolo. E si cammina in banchina, al centro strada del suicidio s’azzarda chi corre veloce. E sfugge a Nostra Signora Morte Corporale con l’ennesima ridente piroetta. Navigando in mare aperto, dove ronzano i pesci volanti e non prende la radio. L’interferenza con l’ala dell’albatro moltiplica le onde: la saetta bianca dell’altrove. Quando il nastro scorre e hai perso il pezzo. L’argano arrugginito non si concede al peso del pescato, e s’allargano le spalle. La esse gravida del flauto di vertebre. Incrinato come le costole di mia madre. E quei riccioli di paglia infuocata, sul Vesuvio bombarolo a percussioni stonate. Fioccano i nontiscordardime sui davanzali abbandonati. Non passasse l’aratro sui fiori dell’odio e dell’amore. Il diagramma olografico era a matita, prima. Poi s’è fatto china rinascente. Spasmodica su fogli nuovi per non decifrare punti sospensivi inchiodati al passato prossimo. Che la memoria oltranzista deforma le immagini e decide da sola cause ed effetti. Uno scienziato pazzo che s’addentra nell’esotica materia del pensiero. Per un qualche eccesso di zelo orfico, nel rovescio del guanto di renna. Il poliestere scadente della debolezza, verde come il grano acerbo e le grandi speranze al microscopio. Fuma l’industria alla finestra, omaggio al capitalismo di certi individui poveri che si vestono di seta orientale. E no, non mi piace il rossetto. E neanche i treni. Si smettono i i vizi per agio, vanità o alternativa più appagante. Che contare le briciole è come non aver mai mangiato pane. Del massimalismo lunare e di altri mostri incauti. Ma questo stupore lucente, nella fagocitosi dell’azzurro intenso, lontano e moderno come la Prussia. Destinato forse a disfarsi: c’è da manifestare nelle piazze e farlo valere come un’ideologia positiva. Vedi sciogliersi in lanterne rosse poi, quell’azzurro di pace, e smettono di abitare le farfalle dove prima c’erano i bruchi. Che c’è troppa gente che innesta e non disinnesca, e asciuga secca inferocisce. E se tu m’infuochi t’amerò di sesso e sangue, odiandoti alla fine perché non dormirò negli artifici e mi prende quella pazzia che non hai saputo addomesticare, sporcandomi di una violenza rinnegata. Ma se mi lasci nel mio azzurro, accarezzandolo nel rispetto di questa rara e abominevole natura, allora non t’amerò subito, e forse domani o in nessun luogo, ma con lentezza suprema e non ti odierò mai. Comunque vada il girotondo dell’instabile intorno. E ci guarderemo dai fuochi fatui ardenti freddi, perché un fiammifero non combatte la notte come i focolari. Se pure li abbiamo lasciati in altre città, per crearne di nuovi. Che il capriccio dell’incostanza ci fa odissiaci e insensati e avidi. Di maschere ne abbiamo spezzate, e se non si vedono più i volti per qualche altrui assuefazione alla copertura ambigua, che trovino altrove gli stessi un cuore che ne sopporti la falsità. Ricordando la differenza tra colla opaca e acqua che scorre. Si cresce guardando il residuo fisso sull’etichetta che ognuno si ricama addosso senza saperlo. Si parla poi agli sconosciuti con infinita dolcezza, tutta quella che ci è stata risparmiata altrove. Perché se non comincio io ad amarti tu non lo farai, non mi abbraccerai per primo. Avrai paura come tutti delle mie mani. Ma non voglio assolutamente niente da te. Se non quegli stessi cinque minuti d’onestà che ti ho deciso sul tram, per un tratto breve. Perché ci dimenticheremo come quando finisce il dentifricio. Io andrò a lavoro e tu pure, di lunedì. Sai, ne ho visti d’inferni e sono sicura che anche tu, in qualche modo. E voglio essere il più libera possibile in questo zoo, e tu? Non dirmi che vuoi marcire come tanti che fanno sempre lo stesso giro. O calpestare gli altri animali per avere più cibo o qualche privilegio insoddisfatto. Di cicatrici trapunte come ornamenti e sguardo acceso, l’essenza del si o del no. Questi che ti sorrido in bocca, baciandoti apollinea. Ho visto creature a cui viene aperta la gabbia restarci dentro perché hanno dimenticato o forse mai saputo cosa c’è fuori. Non essere in grado di godere mai niente, ma volere sempre tutto. Gonfi d’egotismo ci aggiriamo immondi sulla superficie delle cose. E col morso di vipera m’innamoro di ciò che prima non vedevo.
Abbracciami adesso, sentirai che sono felice.
Delia Cardinale