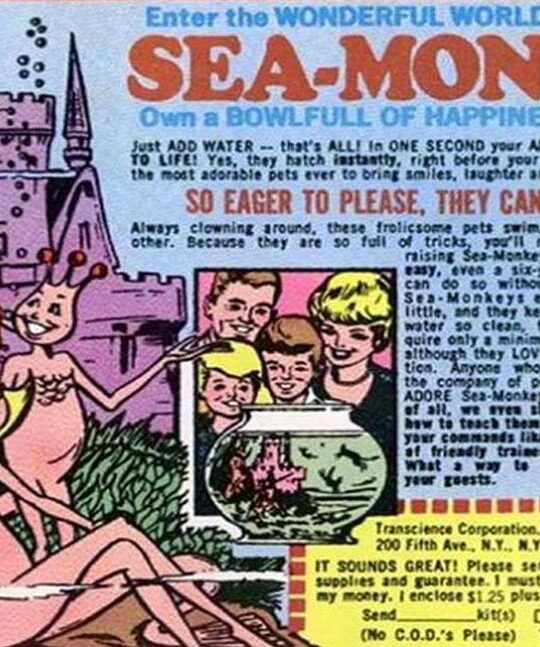Mémoires d’un fou
Il sole calava nella sabbia, i cammelli e le giumente dormivano, un insetto ronzava attorno alle loro mammelle, il vento della sera ci accarezzava. E una volta scesa la notte, quando quella luna d’argento proiettava i suoi pallidi sguardi verso il deserto, quando le stelle brillavano nel cielo azzurro, allora, nel silenzio di quella notte calda e profumata, sognavo di gioie infinite, di voluttà celesti. Ed era ancora la gloria, con i suoi applausi, le sue fanfare che si innalzano nel cielo, i suoi allori, la sua polvere d’oro gettata ai venti; era un brillante teatro con donne eleganti, diamanti per luci, un’aria pesante, petti ansanti; poi un raccoglimento religioso, parole ardenti come l’incendio, pianto, riso, singhiozzi, l’ebbrezza della gloria, grida d’entusiasmo, il trambusto della folla, che altro! Vanità, rumore, nulla. Da bambino, ho sognato l’amore; da giovane, la gloria; da uomo, la tomba, quest’ultimo amore di chi non ne ha più. Vagheggiavo anche l’epoca remota dei secoli andati e di razze ormai addormentate sotto l’erba; vedevo la schiera dei pellegrini e dei guerrieri marciare verso il Calvario fermarsi nel deserto morendo di fame, implorando quel Dio che andava a cercare e, stanca delle proprie bestemmie, marciare sempre verso quell’orizzonte senza limiti; poi, esausta, ansimante, giunta finalmente alla meta del proprio viaggio, disperata e vecchia, per abbracciare soltanto qualche arida pietra, retaggio del mondo intero. Vedevo i cavalieri correre sui loro destrieri.
E poi ancora la notte, nell’oscura cattedrale, con tutta la navata ornata da una ghirlanda di folla che sale verso la volta, nelle gallerie, intonando canti; luci che risplendono nelle vetrate e, nella notte di Natale, tutta la vecchia città, con i suoi tetti aguzzi coperti di neve, illuminarsi e cantare. Ma era Roma che amavo, la Roma imperiale, questa bella regina che si rotola nell’orgia, sporcando la sua nobile veste con il vino della depravazione, fiera dei suoi vizi più che delle sue virtù. Nerone! Nerone, con i suoi carri di diamante che volano nell’arena, le sue mille vetture, i suoi amori di tigre e i suoi banchetti di gigante. Lontano dalle lezioni classiche, mi riconducevo verso le tue immense voluttà, verso le tue illuminazioni sanguinose, verso i tuoi divertimenti che bruciano Roma. E, cullato in queste vaghe fantasie, sogni proiettati nell’avvenire, trascinato da questo pensiero avventuroso scappato come una giumenta senza freno, che supera con un balzo i torrenti, scala le montagne e vola nello spazio, restavo per ore intere, con la testa tra le mani, a guardare il soffitto dello studio, o un ragno costruire la sua tela sulla cattedra del nostro maestro; e quando mi svegliavo con gli occhi spalancati, gli altri ridevano di me, il più pigro di tutti, io che non avrei mai avuto un’idea concreta, che non mostravo inclinazione per nessuna professione, inutile in questo mondo dove ciascuno deve prendersi la sua fetta di torta, insomma uno che non sarà mai buono a nulla, tutt’al più a fare il pagliaccio, il domatore di animali o l’autore di libri. Facevo sogni, incubi spaventosi. Oh!… Che epoca triste e uggiosa! Mi vedo ancora errabondo, solo, nei lunghi e bianchi corridoi del collegio, guardare i gufi e le cornacchie che spiccavano il volo dalle guglie della cappella, oppure coricato in quei cupi dormitori rischiarati da una lampada dove l’olio gelava. Durante le notti, ascoltavo a lungo il vento che soffiava lugubremente nei vasti appartamenti vuoti, che sibilava nelle serrature facendo tremare i vetri nei loro telai; udivo i passi dell’uomo di ronda che camminava lentamente con la lanterna; quando si avvicinava verso di me, facevo finta di dormire, e in effetti mi addormentavo, per metà tra i sogni e per metà tra le lacrime.
Ecco come ero, sognatore, svagato, con un’indole indipendente e beffarda, intento a costruirmi un destino tutto mio e assorto nella poesia di un’esistenza piena d’amore, vivendo già di ricordi, per quanti se ne possano avere a sedici anni. Il collegio mi era antipatico. Sarebbe interessante studiare questa sorta di profondo disgusto che le anime nobili ed elevate manifestano al contatto e all’urto con gli uomini. Non mi è mai piaciuta una vita disciplinata, ore fisse, un’esistenza regolata dall’orologio, dove il pensiero deve fermarsi con il rintocco, dove tutto è masticato in anticipo per secoli e generazioni. Questa regolarità converrà probabilmente alla maggior parse degli individui, ma per un povero fanciullo che si nutre di poesia, di sogni e di chimere, che pensa all’amore e a tutte le scempiaggini possibili, è come svegliarlo incessantemente da questo sogno sublime, non lasciargli un solo momento di requie, soffocarlo riportandolo nella nostra atmosfera di materialismo e di buon senso di cui egli prova orrore e disgusto. Me ne stavo in disparte, con un libro di versi, un romanzo, una poesia, qualcosa che potesse far sussultare quel cuore di giovane uomo, vergine di sensazioni e cosi desideroso di averne. Rammento con quanta voluttà divorai allora le pagine di Byron e di Werther; con quale trasporto lessi Amleto, Romeo e Giulietta, e le opere più veementi della nostra epoca, tutte quelle opere, insomma, che sciolgono l’anima in delizie, che la fanno ardere di entusiasmo. E cosi mi nutrii di quella poesia aspra del Nord, sonora come le onde del mare nelle opere di Byron. Spesso, alla prima lettura, ne ricordavo a memoria brani interi, e li ripetevo a me stesso, come una canzone che ti abbia ammaliato e la cui melodia ti insegua costantemente.
Quando finirà dunque questa società imbastardita da tutte le dissolutezze, dissolutezze dell’intelletto, del corpo e dell’anima? Allora tornerà certamente la gioia sulla terra, quando questo vampiro bugiardo e ipocrita che si chiama civiltà sarà morto; si abbandoneranno il manto regale, lo scettro, i diamanti, il palazzo che crolla, la città che va in rovina, per andare a raggiungere la giumenta e la lupa. Dopo aver trascorso la sua vita nei palazzi e dopo essersi logorato i piedi sul selciato delle grandi città, l’uomo andrà a morire nei boschi. La terra sarà inaridita dagli incendi che l’avranno arsa e, ricoperta interamente dalla polvere delle battaglie, dopo che l’alito di desolazione passato sugli uomini sarà passato anche sopra di essa, non darà più se non frutti amari e spini, e le razze si estingueranno sul nascere, come le piante battute dai venti che muoiono prima di aver fiorito. Poiché tutto dovrà pur finire, e la terra sarà certo consumata a furia di essere calpestata; poiché l’immensità deve pur essere stanca infine di questo granello di polvere che fa tanto rumore e turba la maestà del nulla. L’oro dovrà pur consumarsi a forza di passare di mano in mano e di corrompere; questo vapore di sangue dovrà placarsi, il palazzo crollare sotto il peso delle ricchezze che nasconde, l’orgia finire e noi tutti ridestarci. Allora scoppierà un’immensa risata di disperazione, quando gli uomini vedranno questo vuoto, quando bisognerà lasciare la vita per la morte, per la morte che mangia, che ha sempre fame. E tutto si creperà per sprofondare nel nulla, e l’uomo virtuoso maledirà la sua virtù e il vizio applaudirà.
Pochi uomini ancora erranti in una terra arida si chiameranno reciprocamente; andranno gli uni verso gli altri, ma indietreggeranno d’orrore, spaventati da se stessi, e finiranno per morire. Che cosa ne sarà allora dell’uomo, lui che è già più efferato delle belve feroci e più vile dei rettili? Addio per sempre, splendidi carri, fanfare e celebrità; addio al mondo, ai suoi palazzi, ai suoi mausolei, alle voluttà del delitto e alle gioie della corruzione! La pietra precipiterà all’improvviso, schiacciata da se stessa, e l’erba vi crescerà sopra.
Gustave Flaubert, Memorie di un pazzo, 1838