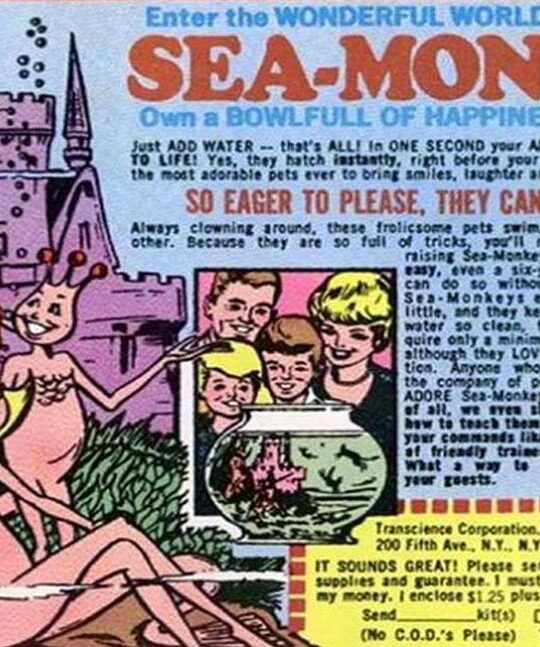Antonio Campobasso, un nero di Puglia.
NERO DI PUGLIA – MAI PORGERE L’ALTRA GUANCIA.
<<Chi sono, chi ero? Ho la pelle nera, i capelli crespi,
gli occhi che si accendono in fuochi delle foreste africane,
ma sono nato in Puglia, figlio della guerra, dall’incontro casuale fra una donna pugliese e un negro californiano.>>
Italia del sud, 1945. Gli Alleati (per noi meridionali chiamati genericamente americani) sono ormai arrivati da tempo; erano entrati nei nostri paesini in sella ai carrarmati, come arriva il circo nei giorni di festa, e qualcuno già se ne va via, torna a casa dai suoi affetti che non vede da almeno tre anni. La guerra è finita, inizia qualcos’altro, anzi, molte altre cose.
A Napoli Edoardo Nicolardi scrive Tammurriata nera, racconta dei bambini nati da madre italiana e padre afro-americano. “I marucchini”. Uno di loro diventerà poi famoso: il sassofonista James Senese, figlio di tal James Smith (soldato americano) e Anna Senese (ragazza della periferia a nord di Napoli).
Dall’altro lato dello stivale, sulla costa adriatica, per la precisione a Giovinazzo in provincia di Bari, nasce Antonio Campobasso. Anche lui figlio di un’italiana e di un soldato afro-americano. Anche lui di carattere ribelle e, lo si scoprirà poi, dalla spiccata sensibilità artistica.
Nel 1980 ha scritto un libro che ormai non viene più stampato e, come tutte le cose veramente preziose, richiede che sia scovano con fatica; nei mercatini, sui siti web dell’usato, nelle soffitte. Il libro s’intitola Nero di Puglia, e a me piace definirla un’autobiografia sincera. È sincera perché non è stata scritta con calma, a carriera ormai consolidata. Sono impressioni a caldo sugli anni appena trascorsi, ancora fumanti di astio. È un libro cattivo, arrabbiato, dai periodi spesso urlati come se appartenessero più ad uno sfogo, piuttosto che ad un’opera narrativa.
I primi anni di vita li passa in orfanotrofio dove si scontra subito con la rigida educazione delle suore che lo gestiscono. A loro dedica l’incipit.
<<Era una monaca barbuta, […] dominava questa classe dell’orfanotrofio di Giovinazzo. La dominava controllando dall’altro di una sua cattedra i banchi, […] o esercitava la religiosa virtù di silenziose scorregge, passando a noi l’accusa di aver appestato l’ambiente.>>
Poche righe ma lapidarie. Tutto termina con l’immagine amara di un bambino, il protagonista, picchiato soltanto perché appare, agli occhi dell’educatrice, allegro.
<<Allora ero allegro e la monaca non mi tollerava, e già a picchiarmi con la bacchetta e a piagarmi le mani.>>
L’incipit finisce, si gira la pagina e ci si trova di fronte a qualcosa di inaspettato, che appare quasi metafisico per quanto è fuori luogo: una poesia.
[…]
E non guarderò mai dove si dimentica,
dove il tuo dio
pendulo sul tuo petto
cancella la mia storia.
E quando sarò stanco di odio,
saprò vestirmi di sole,
mi leccherò come una iena
le ferite
che segnasti nel cuore di un bambino,
di mille bambini, facendoli fiaccole spente.
In tue pagine è l’essenza del libro: prosa alternata a poesia per raccontare il dolore dello stare al mondo e subirne la cattiveria.
In un’intervista di molti anni dopo, quando gli venne chiesto che senso ha per lui la poesia, Antonio Campobasso rispose: “Le mie poesie in realtà sono delle bestemmie”.
I versi sono rabbia condensata in parole, senza spazio per il romantico, per la speranza. Non sono una denuncia, non vogliono esserlo. Sono una vera e propria maledizione.
Si diplomerà a Roma, nel ‘78, presso lo “Studio di Arti Sceniche” di Fersen, ma prima lo aspettano anni di vagabondaggio, di fame, di permanenza nei collegi e, soprattutto, nelle carceri statali.
“Esistevo in quanto nome negli atti di un processo” racconterà in età ormai matura. Il colore della sua pelle e la sua estrazione sociale gli fanno conoscere i due volti del razzismo: quello della “razza” e quello della “classe”. È in questi momenti che la sua poesia si trasforma, ma non completamente, da bestemmia a preghiera:
Non mandatemi
in paesi stranieri
perché la mia pelle è diversa.
Il mio cuore pende
con il suo ritmo intenso
dai muri del sud.
Il parallelo con la nostra cronaca contemporanea viene facile. In questa storia ci sono migliaia di altre storie, il destino comune dei “figli della guerra” che si ritrovano privati di un’identità umana, classificati e catalogati dalla burocrazia dell’accoglienza; soluzione palliativa e, al tempo stesso, definitiva perché quella vera, quella utopica del dover debellare la guerra, non è contemplabile dai Signori del Capitale. E allora forse si dovrebbe, come piccola rivincita retorica, smettere di chiamarli “figli della guerra” in favore di un più sincero “figli delle bombe”, le nostre, tra l’altro.
Alla fine Antonio Campobasso, un negro pugliese, troverà la “salvezza” riuscendo a studiare recitazione e a lavorare nel mondo del cinema. Questo però lo sappiamo da altre fonti, il romanzo termina prima, dove ancora non si vede speranza. Perché?
Perché il passato non sia attutito dal presente, perché, se è vero che il lieto fine chiude la storia, spesso ne rovina anche il messaggio.
Qual è quindi in messaggio di questo libro? Non ne esiste uno solo, ne sono convinto. Per quale libro ciò accade? Uno dei tanti, forse (ma è un forse assai dubbioso) il principale lo si trova nella parole dello stesso autore: “Spero che sia un’esortazione a non porgere l’altra guancia” perché, ci dice, “Non è tempo di Vangelo, questo”.
Raffaele Montesano